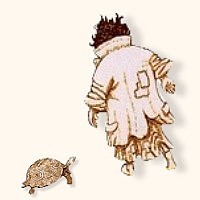Un emergere di rossori, imbarazzi e timori che aprono comunque alla percezione dell'Alterità.
La parola vergogna deriva dal latino vereor, che significa rispetto, timore rispettoso, mentre il corrispettivo inglese, shame, si ricollega alla radice indoeuropea kam, che significa nascondere, coprire; dunque l'uno mette l'accento sulla motivazione scatenante (positiva: il senso di rispetto), l'altra sull'azione conseguente (il nascondere, velare). In effetti dal punto di vista fenomenologico il senso della vergogna viene descritto come:- un senso improvviso e sgradevole di nudità, di sentirsi scoperti, spogliati, smascherati, - il conseguente desiderio di sparire, di sprofondare, di diventare invisibili, - un senso di paralisi, di blocco, un sentirsi irrigiditi, pietrificati.La sensazione generale che ne deriva è una sorta di profondo turbamento, di disorientamento, di confusione, desiderio di fuga e di blocco dell'azione.La vergogna è conseguente ad una sensazione di smascheramento: cade la maschera, ciò con cui ci si tende a coprire, a proteggere, l'intimità del proprio sé e l'immagine di sé diventa improvvisamente evidente all'occhio esterno, alla vista degli altri; ci si percepisce nudi, esposti allo sguardo altrui, visti per come si è e non si ci si sarebbe voluti mostrare. In genere il senso di vergogna è associato al rendersi improvvisamente evidenti di quei lati di noi che consideriamo sgradevoli, indecenti, o addirittura mostruosi.A differenza di questo il pudore, come vedremo, ha una sfumatura leggermente più tenue: esso pone l'accento sul bisogno di proteggere qualcosa di intimo che tuttavia non è necessariamente vissuto come inadeguato o sgradevole.Il senso della vergogna si pone su un piano di esperienza piuttosto immediata, di tipo percettivo, particolarmente associata al senso della vista: è legata ad un'immagine visiva che si fa evidente, che non è necessariamente ancora parola, e quindi pensiero.Spesso proprio quando diventa dicibile, quando passa cioè dal piano percettivo a quello del pensiero, perde parte della propria intensità. Arrivare a dire che si prova vergogna e a individuare che cosa genera tale sensazione spesso segna l'inizio dell'elaborazione che può portare dall'accettazione, all'ironia, fino all'autoironia liberatoria.Tuttavia, pur essendo immediata e percettiva, fa parte delle cosiddette emozioni complesse, che richiedono cioè un certo grado di evoluzione, in quanto fa riferimento ad un modello del sé già esistente e ad un insieme di regole sociali, più o meno esplicite, con cui quell'immagine di sé si trova direttamente in relazione: la vergogna richiede quindi un certo livello di coscienza. Esiste poi uno specifico carattere corporeo della vergogna: spesso il corpo viene particolarmente chiamato in causa da questa emozione e ne diventa il supporto espressivo. Il sé difettoso si "incarna" per così dire nel corpo che si trasforma nell'oggetto vergognoso da nascondere: la mimica della vergogna lo esprime bene con i gesti di ripiegamento su se stessi, l'abbassare gli occhi, coprirsi la bocca o altre parti del corpo.Vergognarsi del proprio corpo, della sua forma, della sua goffaggine o rigidità di movimento è un modo piuttosto immediato attraverso cui si esprime la vergogna di sé, la non accettazione, l'autogiudizio e l'autocondanna.L'intensità del vissuto di vergogna è variabile: quando è sentita come insopportabile la vergogna viene nascosta o più spesso camuffata in rabbia, odio, invidia o depressione, apatia, ritiro. Sul piano interpersonale la vergogna è spesso associata ad un atteggiamento di sottile competizione, in cui mi percepisco irrimediabilmente perdente, in cui l'altro - generalmente un "altro" significativo - diventa luogo di proiezione dei vari aspetti del mio sé ideale, diviene rappresentante di Tutti gli Altri, (più belli, più sani, più adeguati, più capaci,…. più "normali" insomma) rappresentante di una norma sociale da cui mi sento dolorosamente esclusa.In questo senso la vergogna si associa facilmente all'invidia ed alla rabbia ad essa connessa. psicoanalisti americani che hanno cominciato ad occuparsi della vergogna (i cosiddetti vergognologi, tra cui Andrew Morrison), hanno ben descritto il cosiddetto "ciclo della vergogna-rabbia".In questo ciclo accade che ci si vergogni di se stessi (del proprio essere troppo passivi, incapaci o comunque difettosi rispetto a qualcun altro), tale vergogna produce un ritiro in se stessi, ma anche risentimento, invidia e rabbia vendicativa verso l'altro contro cui ci si scaglia, almeno mentalmente. Questa aggressione genera colpa, ulteriore ritiro nella passività e quindi aumento di vergogna, per cui il ciclo alimenta se stesso.La relazione amorosa mette in ballo inevitabilmente il conflitto tra due esigenze fortemente contrastanti ma compresenti:- il bisogno di attaccamento e di legame, di entrare in rapporto profondo con l'altro, di sentirsi intimamente uniti e di fondersi con lui, - il bisogno di separatezza e distinzione dall'altro, di autonomia ed indipendenza, di mantenere la propria individualità, la propria soggettività.Queste due esigenze sono spesso percepite come due poli contrapposti, inconciliabili, che portano o all'autonomia con esclusione del rapporto d'amore, o al rapporto d'amore con perdita di autonomia.Eppure sono entrambe esigenze ineliminabili, fondanti il nostro essere umani.Come risolvere questa ambivalenza?Freud così si esprimeva in proposito al possibile malessere connesso a tale conflitto:"Un forte egoismo instaura una protezione contro la malattia; tuttavia, prima o poi bisogna ben cominciare ad amare per non ammalarsi e se, in conseguenza di una frustrazione, si diventa incapaci di amare, inevitabilmente ci si ammala." [Da Introduzione al Narcisismo] Dunque, nel rapporto intimo con l'altro, bisogna ogni volta tornare a separarsi, a distanziarsi, a differenziarsi per poter amare, ma bisogna anche essere sufficientemente disposti a perdere di vista sé in favore dell'altro, senza che questa perdita diventi mai totale e distruttiva della propria soggettività.In questo senso il pudore, nell'accezione suddetta, può porsi come strumento che aiuta a trovare un equilibrio, seppure delicato, fragile e precario, tra queste due esigenze, di fusione e autonomia, grazie alla sua funzione di mediazione, di moderazione, che stempera il rischio di assolutismo insito in entrambi i poli.Il vissuto del pudore mantiene vivo il problema dell'alterità, della differenza, della separatezza tra i due, proprio laddove essi si incontrano nell'intimità del loro essere.Comporta l'accettazione del limite, di una vicinanza, di una somiglianza che permane sempre relativa, di uno spazio mai completamente annullato tra l'Uno e l'Altro.Il pudore è ciò che contiene la tendenza ad invadere e farsi invadere, a pretendere una somiglianza o concordanza eccessiva, che tenderebbe a negare le differenze e annulla le distanze; è un rispetto di fondo che contiene gli eccessi presenti nelle fantasie di fusionalità e di prevaricazione reciproca.